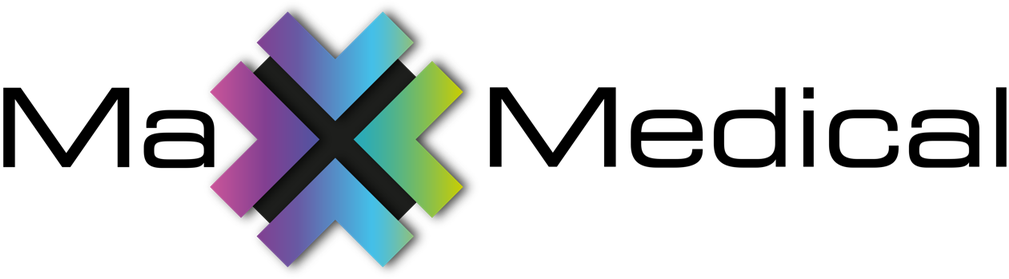L’aderenza alla terapia farmacologica rappresenta un elemento fondamentale nel
processo di cura dei pazienti affetti da patologie cronico-degenerative e nel
raggiungimento degli obiettivi clinici stabiliti dai curanti. Nella sua accezione più
ampia, essa indica la misura in cui il comportamento di una persona corrisponde alle
raccomandazioni ricevute dal suo medico o professionista sanitario relativamente ai
tempi, alle dosi ed alla frequenza nell’assunzione dei farmaci prescritti per l’intero
ciclo di terapia (1,2).
La rilevanza della tematica è evidente se si considera l’elevata prevalenza di malattie
cronico-degenerative nella popolazione italiana che tende ad aumentar e all’avanzare
dell’età: il 39,7% degli italiani soffre di almeno una malattia cronica, percentuale
che sale all’85,3 % negli ultrasettantacinquenni; la copresenza di due o più di esse si
registra nel 20,7% della popolazione, arrivando al 66 % dopo i 75 anni. In
particolare, i valori di prevalenza di ipercolesterolemia e di ipertensione arteriosa, i
maggiori fattori di rischio per malattie cardiovascolari, sono rispettivamente del
22,70 e 17,4 %; il 5,3% della popolazione ha una diagnosi di diabete mellito (DM),
di cui oltre il 90% dei casi è rappresentato da DM di tipo 2 (3,4).
Per queste patologie, la non aderenza rappresenta un problema sanitario di portata
globale: secondo numerose evidenze di letteratura, essa interessa almeno la metà dei
pazienti cronici nei Paesi sviluppati (5).
L’Italia non fa eccezione: in un recente studio
trasversale, fino al 53,9 % dei pazienti affetti da una patologia cronica ammette di
aver dimenticato almeno una volta l’assunzione delle terapie prescritte nel corso
dell’ultimo mese (6).
Stando alle analisi contenute nel Rapporto OsMed 2013,
l’assunzione con continuità della terapia si registra solo nel 62,1 % dei pazienti in
trattamento antidiabetico, nel 55,1% dei soggetti in terapia antipertensiva, arrivando
al 43,0 % dei pazienti che assumono statine (7).
I principali determinanti riconosciuti della non aderenza al trattamento sono l’età
avanzata (l’Italia è il secondo paese più vecchio al mondo) (3) e la politerapia,
condizione diffusa ed in continuo aumento con cui si intende l’assunzione
contemporanea di cinque o più farmaci (5).
I fenomeni sono fra loro intimamente connessi, dal momento che l’età avanzata comporta un maggior rischio di
comorbidità e necessità di politerapia, ulteriormente aggravate dalla frequente
presenza di deficit cognitivi, funzionali e sensoriali. La prevalenza d’utilizzo di
almeno un farmaco passa dal 45% negli adulti ad oltre il 90% degli
ultra settantacinquenni; d’altra parte, ogni anziano assume in media più di tre farmaci
al giorno.
Una recente indagine dell’AIFA ha trovato che l’l 7% della popolazione
anziana (più di 1,3 milioni di persone) arriva ad assumere più di dieci farmaci al
giorno; in particolare, il gruppo di età tra i 75 e gli 84 anni è esposto al più alto carico
farmacologico, con il 55% dei soggetti trattati con cinque-nove farmaci e il 14% o con
dieci o più farmaci (8).
In generale, la non aderenza alle prescrizioni del medico costituisce la principale
causa di non efficacia delle terapie farmacologiche. Inoltre, l’assunzione di un
dosaggio eccessivo, la non assunzione o dimenticanza, o ancora la variazione dello
schema terapeutico e della dose potrebbero aumentare il rischio di eventi avversi
farmaco-correlati. Per tali motivi, la non aderenza risulta associata ad un aumento
degli interventi di assistenza sanitaria nonché degli indici di morbilità e mortalità,
arrecando danno sia ai pazienti che al Servizio Sanitario Nazionale (9,10).
Si stima che ogni anno in Europa essa provochi 194.500 decessi e comporti un costo di circa 125
miliardi di euro, rappresentando fino al 14 % del totale della spesa sanitaria (11,12);
negli Stati Uniti, la cifra arriva a 300 miliardi di dollari l’anno (13).
Come sottolineato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, “aumentare
l’efficacia di adesione alla terapia potrebbe avere un impatto maggiore sulla salute
più di qualsiasi miglioramento medico specifico” (3). Il semplice aumento
dell’aderenza dei pazienti alla terapia prescritta comporta come inevitabile
conseguenza un iniziale aumento dei costi legati al trattamento farmacologico.
Tuttavia, esso può, sul lungo termine, abbassare complessivamente i costi sanitari,
attraverso una riduzione delle complicanze associate alla malattia, una diminuzione
dei tassi di ospedalizzazione e di accesso ai servizi di emergenza, una maggiore
sicurezza ed efficacia dei trattamenti (14,15). In Italia, il risparmio ottenibile
raggiungendo l’80% dell’aderenza ai programmi terapeutici nelle patologie croniche
è stimato in 11,4 miliardi di euro/anno (16).
L’aderenza alle terapie è dunque riconosciuta
come “determinante dell’efficacia di un sistema sanitario” (3) ed è di fondamentale importanza
per la sostenibilità del SSN italiano.
Migliorare l’aderenza rappresenta una sfida complessa: diversamente dal concetto
di compliance, quello di aderenza presuppone un ruolo attivo del paziente, che è
partecipe e responsabilizzato rispetto al proprio percorso di cura stabilito insieme al
medico (3). L’implementazione di strategie innovative di packaging del farmaco può
costituire un valido aiuto per il paziente nel mantenimento di un livello di aderenza
ottimale. In particolare, il blister packaging consiste nel confezionamento di blister
mensili (tempo massimo previsto per la domiciliarità) personalizzati, in cui ogni slot
contiene tutte le diverse compresse/capsule che il paziente deve assumere nei diversi
momenti della giornata per ogni giorno di trattamento.
Questo sistema risulta essere particolarmente funzionale in quanto offre
maggiori possibilità di monitoraggio dell’assunzione della terapia, sia da parte del
paziente stesso che del caregiver.
Esistono già molteplici evidenze di letteratura nel contesto europeo ed internazionale
a sostegno del miglioramento dell’aderenza alla terapia farmacologica attraverso
soluzioni di blister packaging (17): i vantaggi risultano particolarmente marcati per le
politerapie, rendendo più agevole l’assunzione di più unità farmaceutiche e
riducendo gli sforzi mnemonici e gestionali demandati al paziente (18). Un servizio
che permette al Farmacista di riacquisire la sua centralità nella gestione del Farmaco
con un lavoro che può essere semplificato e reso più sicuro attraverso l’adozione di
tecnologie idonee al tipo di Servizio previsto. Con l’obbiettivo principe del
miglioramento dello stato di salute attraverso la maggior
aderenza alla terapia (17) la Farmacia ha la possibilità di fidelizzare il paziente cliente.
Ricerca bibliografica
1) Haynes RB. Determinants of compliance: The disease and the mechanics of treatment. Baltimore MD,
Johns Hopkins University Press, 1979. 3.
2) Rand CS. Measuring adherence with therapy for chronic diseases: implications for the treatment of
heterozygous familial hypercholesterolemia. American Journalof Cardiology 1993,72:68D-74D.
3) Istituto nazionale di statistica (Istat). Indagine Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana
– parte generale (2017).
4) EpiCentro. La sorveglianza Passi – Rischio cardiovascolare. Periodo 2014-2017. Disponibile al link:
http://wum,.epicentro.iss.itlpassi/dati/cardiovascolare.asp.
5) World Health Organization. Adherence to Long-Term Therapies – Evidence for Action. Geneva,
Switzerland (2003).
6) Napolitano F, Napolitano P, Angelillo IF, Collaborative Working Group. Medication adherence
among patients with chronic conditions in ltaly. Eur J of Public Health 2016; 26 (I): 48-52.
7) Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali
(OSMED). L’uso dei farmaci in Italia – Rapporto Nazionale Anno 2013. Roma (2014).
8) Onder G, Marengoni A, Russo P, et al. Advanced age and medication prescription: more years, less
medications? A nationwide report from the Italian Medicines Agency. JAMDA 2016;11 (2): 168-172.
9) Cramer JA, Roy A, Burrell A, et al. Medication compliance and persistence: Terminology and
definitions. Value Health 2008; l1: 44-41.
10) Zulligg LL, Peterson ED, Boswomh HB. Ingredients of successful interventions to improve medication
adherence. JAMA 2013; 3 l0: 261 1 -2612.
11) Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005; 353: 487-497.
12) European Federation of Pharmaceutical lndustries and Associations (EFPLA.), New England
Healthcare Institute. A System-wide Approach to lmproving Patient Medication Adherence for
Chronic Disease (2009).
13) Senst BL, Achusim LE, Genest RP, e/ al. Practical approach to determining costs and frequency of
adverse drug events in a health care network. Am J Health Syst Pharm 2001; 58: 1126-1132.
14) Rosen OZ, Fridman R, Rosen BT, et al. Medication adherence as a predictor of 30-day hospital
readmissions. Patient Prefer Adherence 2011; 11: 801-810.
15) Gelzer AD, Gao W, Keleti D, et al. Multifaceted interventions improve medication adherence and
reduce acute hospitalization rates in medical patients prescribed asthma controllers. J Asthma 2018
Mar 22: l-10.
l6) Senior Italia FederAnziani. Comunicato stampa n. 1412017 – Aderenza alla terapia, Senior Italia
FederAnziani: con troppe pillole salute anziani a rischio. Roma (2017).
17) Conn VS, Ruppar TM, Chan KC, et al. Packaging interventions to increase medication adherence:
systematic review and meta-analysis. Curr Med Res Opin 2015;31 (l): 145-60.
18) Mahtani KR, Heneghan CJ, Glasziou PP, et a/.
Reminder packaging for improving adherence to self-administered long-term medications.
Cochrane Database Syst Rev 201 1 Sep 7; (9): CD005025.